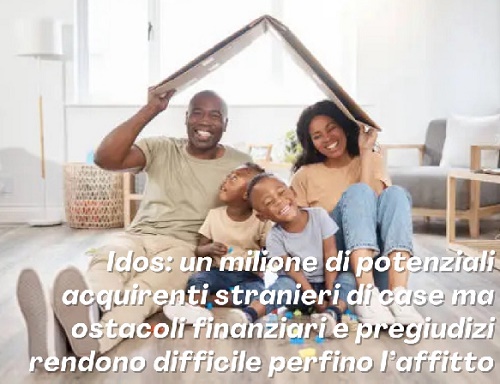Dopo il boom nel primo decennio del secolo, il mercato ristagna. Oggi solo 1 compravendita su 20 riguarda immigrati e solo un quinto di essi ha un’abitazione di proprietà. Garanzie insostenibili, alte spese iniziali e discriminazioni le maggiori difficoltà. E per i rifugiati spesso c’è solo l’esclusione
AgenPress. Almeno 1 milione di residenti stranieri (1 su 5 in Italia!) potrebbe acquistare casa. Ma pur avendo un reddito sufficiente per sostenere un mutuo, essi non possono comprarla. Così, solo il 20% di chi ha la cittadinanza straniera vive oggi in una casa di proprietà, contro l’80% degli italiani.
È uno dei paradossi svelati dal Dossier statistico immigrazione 2025, che il Centro studi e ricerche Idos presenterà a Roma e in tutte le regioni italiane il prossimo 4 novembre. Il capitolo, curato dall’Istituto Scenari Immobiliari, aggiorna fino al dato di stima del 2025 i numeri sulle compravendite di abitazioni da parte di persone con cittadinanza straniera negli ultimi 20 anni: un periodo in cui ne sono state acquistate circa un milione in totale, con un volume d’affari di oltre 110 miliardi di euro.
La tabella mostra una timida ripresa del mercato: dal 2020 in poi il numero di case acquistate si è aggirato in media sulle 30 mila unità annue, pari a meno del 5% del totale; nel 2025 questa soglia potrebbe essere di poco superata, arrivando a 39 mila compravendite (5,1%). Il dato positivo va però bilanciato alla luce di due fattori: anzitutto, l’attuale incidenza di un ventesimo degli acquisti complessivi è ben lontana dalle percentuali registrate nello scorso decennio, che si sono attestate tra l’8 e il 10%; ma lo è soprattutto dal quadriennio 2006-2009, quando gli stranieri avevano comprato ben 440 mila abitazioni, contribuendo a una quota tra un quinto e un ottavo del totale.
Il secondo fattore è la collocazione delle abitazioni: tra il 2006 e il 2025 le case acquistate nel centro delle città capoluogo sono passate dal 10,1 al 3,6% del totale; e quelle nel “semicentro” addirittura dal 24,7 al 3,8%. Dall’altra parte, le abitazioni comprate in periferia sono salite al 35,4% (dal 26,6%) e quelle nei comuni più piccoli della provincia al 57,2% (dal 38,6%).
ITALIA. Andamento delle compravendite di case da parte di stranieri e relativo fatturato (2006-2025)
| Anno | N° compravendite | Var. % annua | % compravendite stranieri su compravendite totali | Fatturato totale (mln di euro) | Var. % annua | |
| 2006 | 131.000 | 12,9 | 16,4 | 15.300 | 27,5 | |
| 2007 | 135.000 | 3,1 | 17,3 | 16.800 | 9,8 | |
| 2008 | 103.000 | -23,7 | 15,1 | 11.700 | -30,4 | |
| 2009 | 75.000 | -27,2 | 12,3 | 8.600 | -26,5 | |
| 2010 | 56.000 | -25,3 | 9,0 | 6.000 | -30,2 | |
| 2011 | 60.000 | 7,1 | 10,5 | 6.200 | 3,3 | |
| 2012 | 47.000 | -21,7 | 10,2 | 4.700 | -24,2 | |
| 2013 | 40.000 | -14,9 | 9,8 | 3.900 | -17,0 | |
| 2014 | 36.000 | -10,0 | 8,7 | 3.300 | -15,4 | |
| 2015 | 39.000 | 8,3 | 8,8 | 3.500 | 6,1 | |
| 2016 | 42.000 | 7,7 | 8,1 | 3.700 | 5,7 | |
| 2017 | 45.000 | 7,1 | 8,0 | 4.000 | 8,1 | |
| 2018 | 51.000 | 13,3 | 8,4 | 4.500 | 12,5 | |
| 2019 | 55.000 | 7,8 | 8,9 | 4.800 | 6,7 | |
| 2020 | 26.000 | -52,7 | 4,6 | 2.200 | -54,2 | |
| 2021 | 32.000 | 23,1 | 4,3 | 2.700 | 22,7 | |
| 2022 | 33.000 | 3,1 | 4,2 | 2.800 | 3,7 | |
| 2023 | 32.000 | -3,0 | 4,5 | 2.700 | -3,6 | |
| 2024 | 35.000 | 9,4 | 4,9 | 3.000 | 11,1 | |
| 2025* | 39.000 | 11,4 | 5,1 | 3.400 | 13,3 |
* Stima a fine anno.
FONTE: Istituto Scenari Immobiliari per il Dossier statistico immigrazione 2025 di Idos.
Il capitolo illustra anche l’andamento degli acquisti di case da parte delle diverse collettività. Oggi 7 abitazioni su 10 acquistate da stranieri appartengono a persone dell’Est Europa (in maggioranza di origine romena): nel 2006 erano meno del 34%. Stabile la quota di cinesi e di stranieri originari dell’India o paesi limitrofi (Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan), attestata attorno al 10% del totale dopo il boom nel quadriennio sopra citato. Marginale l’incidenza dei migranti africani: 4,8%, in massima parte da paesi del Nord Africa (che però erano al 14,0% nel 2006). Chiudono il Sud America (1,3% contro il 7,0% del 2006) e le Filippine (0,9%), mentre tutti gli altri totalizzano insieme lo 0,8%.
Ma perché il milione di potenziali acquirenti stranieri non riesce a concretizzare l’acquisto? Il motivo è di natura doppiamente finanziaria. Da una parte, pur potendo permettersi la rata media mensile di un mutuo per la casa (tra i 500 e i 700 euro), gli stranieri di solito non hanno i risparmi per sostenere le spese iniziali (anticipo, spese notarili, commissioni per l’agenzia ecc.). Dall’altra, lo stesso accesso a un prestito bancario diventa spesso impossibile per le garanzie proibitive richieste dagli istituti di credito.
Un meccanismo di esclusione che diventa discriminazione vera e propria quando – salvo alloggiare nel posto di lavoro o presso parenti o connazionali – il cittadino straniero affronta l’unica alternativa disponibile: l’affitto. Qui i problemi riguardano, in moltissimi casi, sia la difficoltà di reperire un’abitazione a causa dei pregiudizi razzisti dei locatori (il “Non si affitta a stranieri” è ormai diventato un avviso esplicitato senza scrupoli), sia i canoni elevati (per gli immigrati ritoccati verso l’alto), sia infine i contratti irregolari o la scarsa qualità degli immobili o il difficile ottenimento di garanzie per una fideiussione.
Una situazione aggravata dalla crescente speculazione immobiliare degli ultimi anni (specialmente a fini turistici), che ha reso soprattutto le case in locazione sempre meno disponibili per intere categorie di persone. Tra queste rientrano in particolare i richiedenti asilo e i rifugiati, come approfondito in un altro capitolo del Dossier 2025.
L’analisi mostra come la diffusa adozione, da parte di diverse Regioni, di discriminatori requisiti di sbarramento verso gli immigrati, per concorrere all’assegnazione di case popolari, o il penalizzante allungamento dei tempi burocratici di lavorazione delle pratiche per loro residenza anagrafica
contribuiscono in modo rilevante alla loro esclusione dal circuito delle abitazioni, colpendo in particolare i titolari di protezione accolti nel sistema di accoglienza istituzionale (centri Sai e Cas). La loro difficoltà di reperire alloggi, al momento di uscire dai centri di accoglienza, fa sì che questi diventino sempre più “domicili permanenti per lunghi periodi” invece che luoghi di transito. L’alternativa è che, esaurito il periodo di accoglienza, questi migranti finiscano nei ghetti delle baraccopoli, dentro roulotte o rifugi autocostruiti, o in immobili occupati, acuendo una condizione di emarginazione e di povertà da cui difficilmente, poi, riescono a uscire.